In apparenza, nulla è più prosaico dei maccheroni: cibo rustico, popolare, che si fa prestare l’identità da un condimento e non posa da primadonna in tavola come, che so, un tacchino farcito o un babà.
Eppure proprio i maccheroni sono forse il cibo che più si è guadagnato spazio nella letteratura, alta e bassa: poesie e trattatelli, motteggi e racconti, e ha persino dato un nome a un intero genere, la poesia maccheronica quattro-cinquecentesca, benché questa con i maccheroni veri e propri abbia poco a che fare.
Quando diciamo maccheroni, qui, intendiamo pasta, in generale: fino agli inizi del ‘900 (e, nelle famiglie napoletane, anche oltre), la parola designava la pastasciutta in tutti suoi formati, che si trattasse di vermicelli o di mezzani, di linguine o tubetti.
L’etimologia del nome è troppo controversa per affrontarla qui, e l’origine dell’alimento lo è ancor di più: forse per questo i letterati si sono sbizzarriti nell’allacciare la nascita del maccherone alla mitologia o ad una primitiva età dell’oro, con intenti comico-parodistici, il più delle volte. Ne narrò una versione leggendaria Matilde Serao, attribuendo la creazione dei maccheroni ad un mago poi espropriato della sua invenzione da una donna “maliziosa, astuta e linguacciuta” che l’avrebbe presentata come propria al cuoco di corte di Federico II di Svevia.
Una fortuna letteraria davvero singolare ha fatto dei maccheroni i protagonisti di poemetti, sonetti, cicalate; parliamo, sia chiaro, di testi burleschi e giocosi, divertissements di letterati che per dar prova del proprio virtuosismo sceglievano di cimentarsi con un argomento vile e plebeo con toni degni della lirica, o della trattatistica, più nobile.
Perciò non mancano le tradizionali invocazioni alle Muse o ad Apollo in apertura dei testi, le dediche a personaggi di spicco, tutti i topoi, insomma, della letteratura “maggiore”.
Nella Tiorba a taccone, pubblicata nel 1646, Felippo Sgruttendio, personaggio misterioso sulla cui reale identità molto si è speculato, inserisce un sonetto dal titolo Maccarune donate da Cecca, in cui declama la meraviglia di un piatto “De cierte saporite maccarune / Semmenate de zuccaro e cannella, / Cosa da fa’ sperire le perzune.”
Da far sperire: da far cioè anelare disperatamente, consumare dal desiderio, addirittura.
A donarglielo è la donna amata, Cecca, e perciò, ne conclude il poeta, “Ammore m’ ha pigliato pe la canna!”: l’amore m’ha preso per la gola.
Chiunque egli sia, Sgruttendio va ben oltre: dedica i 174 versi de Le laude de li maccarune a celebrare la gloria golosa della pastasciutta, passando dal desiderio divorante – è il caso di dire – di saziarsene all’aspirazione catartica ad annullarsi in essa:
“Sango mio,
Gran golio,
De sta vita arce patrune,
Io speresco,
Scievolesco
De provarve, o maccarune!
Se ve trovo,
Se ve provo,
Che gran gusto me ne piglio!
Se ve gliotto
Me n’abbotto
De docezza me squaquiglio.”
(Sangue mio,/ grande brama,/ arcipatroni di questa mia vita,/ io anelo, / svengo dal desiderio / di assaggiarvi, maccheroni! / Se vi trovo / se vi provo / che grande piacere ne traggo! / Se vi inghiotto / mi gonfio di voi / e mi sciolgo per la dolcezza.)
“Fa, gran Giove,
Se te move
Lo pregare a passione,
Se Narciso
in sciore è ammiso,
Ch’io diventa maccarune!”
(Fa, grande Giove,/ se ti muove / a compassione la mia preghiera,/ che come Narciso / fu mutato in fiore, / io diventi maccherone).

Pochi anni più tardi, nel 1654, Francesco de Lemene da Lodi ci dimostra che l’epopea dei maccheroni non è argomento solo meridionale. Il suo poema burlesco, Della discendenza e nobiltà de’ maccheroni, parte da lontano: da quando la Madre Terra genera Frumento grazie al seme gettato dal contadino, e Frumento, franto dalla mola, diviene Farina, “alta Donna, e gloriosa, di cui vola il gran nome a entrambi i Poli”. Da essa discendono figli e nipoti: e se Polenta e Lasagna saranno creature dalla scarsa discendenza (la prima annega in una grassa laguna di burro senza lasciare eredi, la seconda ha una figlia e un figlio, la Torta e il Raviolo, e la linea si estingue), una linea più feconda deriva dall’unione di Pasta e Torchio: da essa viene generato Maccarone, l’eroe del poema, “L’inclito, il sempre magno, e prelibato.”
Tale è la grandezza dell’eroica creatura che il poeta si dichiara indegno di cotanto soggetto ed evoca addirittura la penna di Torquato Tasso:
“Degno tu sei, che solo di te canti
Quel che con tromba eroica ed immortale
Cantò l’armi pietose, e’l Capitano“
Peregrinando, l’avventuroso Maccarone giungerà in Lombardia, dove incontrerà due compagni che si legheranno a lui indissolubilmente: il burro e il formaggio. Era infatti con questi e con null’altro che, un tempo, si usava condire i maccheroni:
“Qua trovò due fratelli, quai repente
In amistà con lui stretti s’uniro
Questi fratei dall’Italiana gente
Son chiamati un Formaggio, ed un Buttiro.
Congiunti poscia insieme eternamente
Uniti ster né mai si disuniro.
E sempre fu veduto il caro stuolo
(Bel Gerion) far di tre corpi un solo.”
Nella storia letteraria dei maccheroni si ritaglia un posto persino Giacomo Casanova, che nelle sue memorie racconta di essere stato invitato, a Chioggia, ad una riunione di accademici maccheronici “nel corso della quale ciascun membro avrebbe recitato un brano di sua composizione”. Così, “dopo aver letto dieci stanze composte per l’occasione” sull’argomento pastasciutta, racconta Casanova, “fui nominato membro per acclamazione. Fui ancor più brillante a tavola che alla riunione, e mangiai tanti maccheroni che mi giudicarono degno di essere proclamato principe.”
Ai primi dell’800, è Camillo Cateni, nella Cicalata in lode de’ maccheroni, a riproporre il tema con toni spiritosamente magniloquenti e moraleggianti. I maccheroni, scrive, non hanno origini incerte, e lungi dal discendere, come pretendono alcuni, da Priapo, da Cerere, dal Dio Pane, sono “figli legittimi del matterello e della madia”, “illustri coniugi” più nobili di quanto si pensi: lo scettro di Giove, la verga degli antichi filosofi, la clava d’Ercole, il caduceo di Mercurio non sono altro che matterelli “da fare i Maccheroni, certo e distintivo contrassegno di padronanza e sopraeminenza; giacchè, come voi sapete, il poter fare i Maccheroni e distribuirgli agli altri significa giurisdizione, autorità, dominio; dicendosi d’uno che è padrone, e che comanda: tale ha la mestola in mano. “ Nientemeno.
E la bontà non è il solo pregio dei maccheroni. Esemplari per innocenza e semplicità, vengono elevati da Cateni a modello di virtù: non affiorano forse candidi e immacolati dall’atro fondo del paiolo?
“Imparate dai Maccheroni, o giovani del nostro secolo, che con tanta facilità vi lasciate ingannare e sviare dalle cattive pratiche, e cadete così debolmente nei pericoli che vi presenta la scostumatezza ed il libertinaggio. Sì Signori, imparate dai Maccheroni, i quali portano il candore dell’innocenza in seno al più nero paiuolo, il di cui tetro colore fa paura fino alla padella, (…) e da quel nero soggiorno escono conservando sempre l’intatte nevi della purità, e dell’illibatezza.”
E non si accontentano solo di un poco di burro e formaggio, “niente curando gli zuccheri, ed i costosi condimenti dell’Indie”, “a dispetto del cattivo esempio che danno loro i pasticci, le sfogliate, le paste frolle, i marzapani, i panpepati, le bocchedidama, le pastereali, e tutte l’altre più effenminate delicatissime biscotterie”?
Sarà poi il bassanese Iacopo Vittorelli a portare il suo tributo all’altare dei carboidrati nella Maccheroneide del 1823, attingendo a un repertorio più convenzionale: ad inventare i maccheroni è infatti Pulcinella, intenzionato ad allietare stomaco e palato degli ospiti della sua festa di nozze.
“Farina dal buratto, acqua dal rivolo
Piglia, e va meditando un capo d’opera.
Fa un bel pastone in men ch’io non descrivolo,
Quinci a stenderlo in falde egli si adopera,
Poscia in tondi cannei le raggomitola,
E que’ cannelli Maccheroni intitola.
Così sta scritto ne’ vetusti codici
Che i Maccheroni un giorno si faceano:
Ora gli spreme il torchio, e in più di dodici
Fogge diverse ogni convito beano.”
Li condisce con burro e formaggio, e l’accoglienza è tale che gli invitati “Giovani, e vecchi al desco si raccolgono, / E i Maccheroni da le man si tolgono.” Finché uno di essi, preso dall’entusiasmo, prorompe in un proclama: anatema e disprezzo verso “Zughetti, fricassee, torte, pastiglie, / Distruggitrici in questa età de gli uomini”, nocive per la salute; “Io vi reputo men de le quisquiglie”.
E invece:
“Ungano i Maccheroni il nostro esofago
Nemici de la febbre, e del sarcofago.
Con un tal cibo, che rallegra gli animi,
Qual cibo v’è che possa mai competere?
Dunque tra i più famosi e più magnanimi
Eroi s’innalzi Pulcinella a l’etere.
Tacque, ciò detto, e i commensali unanimi
Fecero plauso, anzi godean ripetere:
Muojan le droghe, che di vita privano,
E i Maccheroni eternamente vivano.”

Difficile superare tale entusiastico elogio se non ricorrendo all’apparato mitologico. Lo fa Antonio Viviani nel suo Li maccheroni di Napoli del 1824. Parte da molto lontano e, per narrare le origini della pasta, tira in ballo gli dei: Cerere e Venere, Vulcano e Partenope. Gli uomini, tapini, con il grano, dono di Cerere, non erano capaci di produrre altro che un rustico pane; ma fu Giove a ispirarli affinché raffinassero l’arte, e Partenope, che “bella donna era e cortese / E d’ogni cosa in sommo grado istrutta, / Per l’amor che portava al suo Paese” discese in compagnia di Venere fino alla fucina di Vulcano, così che il divino fabbro potesse creare uno strumento nuovo: il torchio. Lo portò nella città di Napoli dove suscitò una meraviglia pari solo a quella che provarono i Troiani di fronte al cavallo proditoriamente allestito dagli Achei: la macchina, opera di alto ingegno, venne presto messa a profitto da quella “gente brava, (…) ripiena di forza e di coraggio”, che creò così “quella composizione / Che volgarmente appellan maccherone.”
Nettare degli Dei, cibo sano più di ogni altro, da quella prima creazione si è evoluto fino ad essere declinato in mille forme:
“Fra questo ceto v’è il maccheroncino,
Riccio di foritana e tagliarello,
Cannarono di prete e fedelino,
Cappelluccio, spaghetto e vermicello:
Lingua di passera e paternostrino,
Di prete orecchio e scorza di nocello,
Lagana, tagliolino e stivaletto,
Lasagna grossa e piccola, e anelletto.
Poscia le punte d’aghi, le stelline,
Che ne van più di mille per boccone,
E le grate a mangiar rose marine,
Li ditali e semenze di mellone;
Li tacchi e di scarola le semine,
Lo gnocchetto e di zita il maccherone,
Acinetti di pepe e laganelle,
Semi di peparoli e tagliarelle.”
Un vero repertorio di formati grandi e piccoli, lunghi e corti, da condire con “buon butirro e parmigiano”, ma anche, ecco la novità, “Intingol di ragù, ch’è moda nuova”.
Il Capitolo in lode de’ maccheroni del 1831, incluso nei Capitoli berneschi in lode de’ maccheroni e de’ pomidori, a firma di un non meglio identificato T. D. G., si apre con la consueta invocazione ad Apollo perché dia forza al canto e prosegue di iperbole in iperbole.
Se tante persone “valenti e dotte”, scrive l’autore, elevarono lodi a castagne e ricotte, salsicce e mele cotte, questi non “furono mai cibi delicati / Da star co’ maccheroni a parallelo”: paragonarli ad essi sarebbe come “voler scioccamente comparare / Una meschina lucciola col sole.”
Persino Omero avrebbe messo la propria arte al servizio dei maccheroni, se ne avesse avuto esperienza, gettando alle ortiche Ulisse e la sua storia senza batter ciglio:
“Se si fosse nel tempo favoloso
Questo piatto sovrano conosciuto,
Non si cantava l’Iliòn famoso;
Ché sol pe’ maccheroni avria tessuto
Un gran Poema, quel valente Omero,
e barattava pure Ulisse astuto.”
Vivanda “ghiotta, ed esquisita” senza la quale ogni tavola è come monca, libera da ogni affanno ed è persino terapeutica:
“Se talun viene afflitto da malori,
E di sanarsi brama all’istante,
Di maccheroni un piatto si divori;
E ancor che si trovasse agonizzante,
Anche la Morte egli potrà fuggire,
Se di siffatto cibo è vero amante.”
Concetto, questo, non nuovo, già espresso da Vittorelli e che verrà condotto alle estreme conseguenze da Gennaro Quaranta.
E vediamolo all’opera, Gennaro Quaranta, che allegramente osa scagliarsi contro il campione della lirica nostrana:
“E tu fosti infelice e malaticcio
O sublime Cantor di Recanati,
che, bestemmiando la Natura e i Fati,
frugavi dentro te con raccapriccio.
Oh mai non rise quel tuo labbro arsiccio,
né gli occhi tuoi lucenti ed incavati,
perché… non adoravi i maltagliati,
le frittatine all’uovo ed il pasticcio!
Ma se tu avessi amato i Maccheroni
Più de’ libri, che fanno l’umor negro,
non avresti patito aspri malanni…
E vivendo tra pingui bontemponi,
giunto saresti, rubicondo e allegro,
forse fino ai novanta od ai cent’anni.”
Eh, sì, è proprio chi immaginiamo, Giacomo Leopardi, il bersaglio di Quaranta: il sublime cantor di Recanati, ne I nuovi credenti, scritto tra il 1835 e il 1836, aveva commesso un imperdonabile affronto alla gloria delle mense partenopee, prendendosela con i maccheroni. E benché volesse in realtà solo alludere all’ostilità da cui si sentiva circondato negli ambienti della cultura napoletana che mal digerivano la sua cupa visione della vita (“…le carte ove l’umana / Vita esprimer tentai, con Salomone / Lei chiamando, qual soglio, acerba e vana,/ Spiaccion dal Lavinaio al Chiatamone,/ Da Tarsia, da Sant’Elmo insino al Molo,/ E spiaccion per Toledo alle persone”) fu fatto oggetto di dileggio per queste incaute parole:
“…in breve accesa
D’un concorde voler tutta in mio danno,
S’arma Napoli a gara alla difesa
De’ maccheroni suoi; che a’ maccheroni
Anteposto il morir, troppo le pesa.
E comprender non sa, quando son buoni,
Come per virtù lor non sien felici
Borghi, terre, provincie e nazioni.”
Un quadro grottesco di una popolazione che non concepisce che la morte sia oggetto d’interesse più rilevante dei maccheroni e che non comprende come si possa essere infelici se si hanno maccheroni buoni a disposizione.
Certo, nessuno poteva prevedere, a quei tempi, che una ben più virulenta ostilità nei confronti dei maccheroni sarebbe stata espressa da Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto della cucina futurista del 1930: propugnando l’abolizione della pastasciutta, il battagliero letterato così argomentava:
“Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso,il roast-beef e il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi il sauer-kraut, il lardone affumicato e il cotechino; ma agli italiani la pastasciutta non giova. Per esempio, contrasta collo spirito vivace e coll’anima appassionata generosa intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci a dispetto della voluminosa pastasciutta quotidiana. Nel mangiarla essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo.”
Scetticismo ironico che Marinetti sperimentò sulla propria pelle quando venne sorpreso da occhi indiscreti a mangiare un piatto di spaghetti, e si ritrovò sbeffeggiato in questi anonimi versi:
Marinetti dice “Basta,
messa al bando sia la pasta”.
Poi si scopre Martinetti
Che divora gli spaghetti.
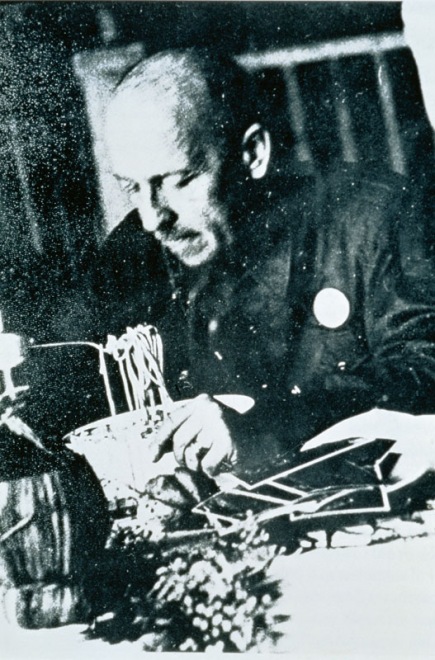
La sua, siamo franchi, era una battaglia insensata, e a dimostrarlo arriverà, nel 1957, un intero volume, Spaghetti dinner, (in seguito ripubblicato con il titolo Maccheroni & C.) a firma nientedimeno che di Giuseppe Prezzolini, che indagava le consuetudini intorno agli spaghetti e il modo in cui venivano percepiti all’estero (o almeno negli Stati Uniti) come simbolo della nazione Italia:
“Gli spaghetti sono penetrati in moltissime case americane dove il nome di Dante non viene mai pronunziato. Inoltre l’opera di Dante è il prodotto d’un singolare uomo di genio, mentre gli spaghetti son l’espressione del genio collettivo del popolo italiano, il quale ne ha fatto un piatto nazionale, ma non mostra di aver invece adottato le idee politiche e il contegno del grande poeta”.
E nel chiudere il volume, piacevole e divertente, Prezzolini scrive, rivolto al lettore:
“Ti sarà venuto certamente in testa che tu ed io avevamo perduto il tempo occupandoci d’una cosa così materiale, così frivola, così comune, e così volgare come i maccheroni. Ma non è vero. Non creder che le speculazioni dei filosofi siano superiori e nemmen molto differenti dallo studio degli spaghetti. (…) Non è vero che la filosofia si trovi soltanto nei trattati dei professori, che ne portano il nome. È da per tutto.”
Mi piace concludere così, prendendo in prestito la prosa di Prezzolini, anche questa lunga divagazione sulla fortuna letteraria del maccherone. Non sarà filosofia, ma “In questo mondo anche il piatto di spaghetti che abbiamo sulla tavola è importante quanto una dottrina filosofica, o rappresenta, nell’affermazione che facciamo della sua importanza e del suo valore, una filosofia. La filosofia degli spaghetti.”

